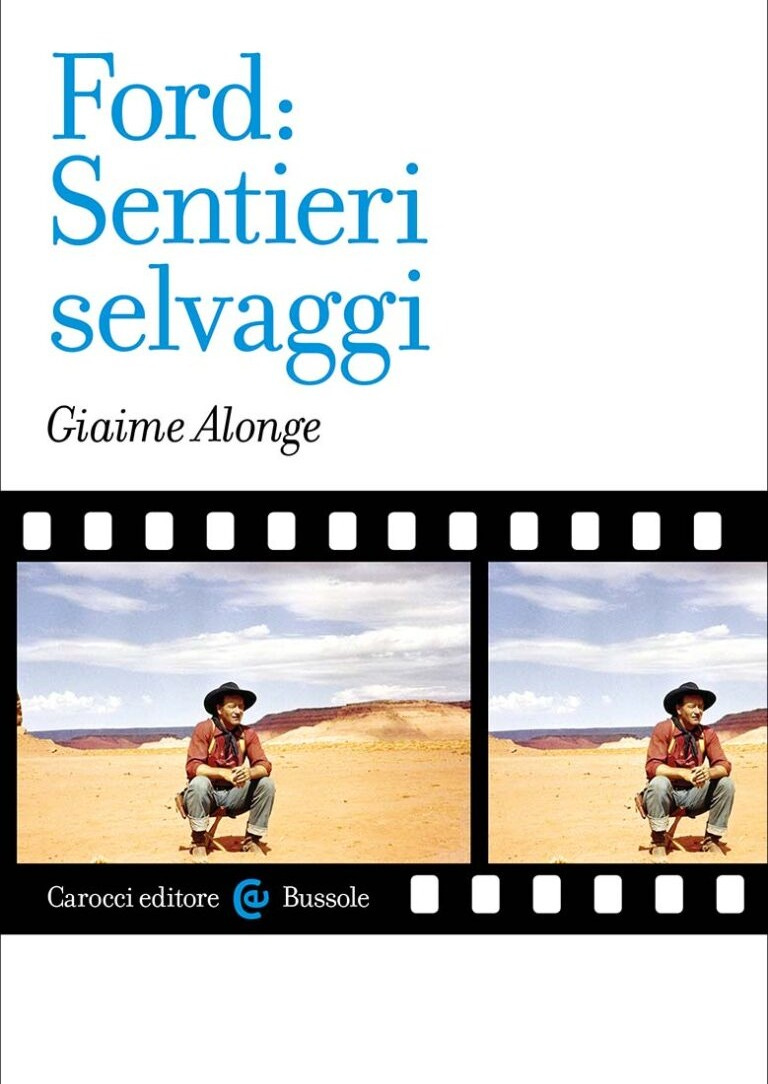Silenzio e voce ritrovata
I nativi americani nel cinema USA
Pensando al personaggio cinematografico di un nativo americano, è probabile che la nostra memoria oscilli fra due distinte immagini: gli “indiani” feroci e spietati di Ombre rosse e Sentieri selvaggi (entrambi di John Ford, rispettivamente del 1939 e del 1956), e il saggio e buono Capo Bromden, interpretato da Will Simpson nel capolavoro di Miloš Forman Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975).
Ma c’è un elemento che accomuna questi due contrapposti archetipi: il silenzio. Raramente, infatti, un nativo americano al cinema è dotato di parola, perché la sua caratteristica principale è l’essere estraneo alla società civile e civilizzata, il luogo dei normali, dei bianchi europei che hanno conquistato un pezzo di terra e il loro posto nel nuovo mondo.
Lo straniero è, per sua definizione, impossibilitato a esprimersi, a usare la parola del Paese in cui si trova e, perciò, ridotto a un silenzio innaturale; e, nel caso dei nativi americani, siamo di fronte alla più grande dissonanza cognitiva mai creata, ossia rendere estraneo e straniero (e perciò ridotto al silenzio) colui che ha le radici familiari più profonde in quel territorio. E il cinema (che da sempre ama e alimenta le disarmonie e le stonature) è riuscito non solo a dare forma a tale dissonanza, ma a canonizzarla.
La scena iniziale di Sentieri selvaggi ne è un esempio tra i più riusciti, come ci racconta Giaime Alonge nel suo Ford: Sentieri selvaggi (Carocci, 2024): «Texas 1868, recita il cartello su sfondo nero. Sullo schermo buio compare un rettangolo luminoso: è una porta, che una donna apre su un paesaggio desertico». Tutto il film è racchiuso in questa prima sequenza: c’è un una vita familiare, conosciuta, comune, e perciò non meritevole neppure di essere mostrata, che si svolge all’interno di un’abitazione qualsiasi. La porta si apre e improvvisamente veniamo accecati dalla vista di un luogo selvatico, dove persino la luce non ha il calore rassicurante che ci aspettiamo. L’intera storia si basa su questa dicotomia: l’ambiente domestico, rappresentato dalla famiglia Edwards, e il fuori, la natura dominata dai pellerossa e dagli uomini solitari che li combattono. Chi non appartiene al mondo civile dei coloni texani, chi non possiede la forza puritana delle donne che governano la casa, chi non indossa i vestiti dai colori tenui ma è contaminato dal colore rosso (che nel film è il protagonista delle scene più violente) appartiene a un mondo silenzioso e pericoloso. «L’idea della bellezza della natura selvaggia è un’invenzione della cultura metropolitana che vi cerca una via di fuga dall’industrialismo», spiega Alonge, citando Roderick Frazier Nash e il suo Wilderness and The American Mind (1967), «ma, per coloro che dovettero affrontare la wilderness, essa non possedeva nulla di bello».
Il silenzio non è mai un atto innocente; e il silenzio che caratterizza i nativi americani nei film di registi come Ford è non solo il riflesso del paesaggio aspro, ma anche l’azione oppositiva che reagisce a un sistema soffocante e dominante. Non è allora un caso se molti degli antieroi solitari che combattono i pellerossa nei film western siano loro stessi taciturni e rappresentati al limite del comportamento civilizzato.
Paradossalmente, ci ricorda Alonge, colui che è chiamato a combattere il nemico e a proteggere lo spazio domestico dalla terra selvaggia diventa lui stesso un solitario, escluso dal sistema sociale-familiare, comunque non in grado di integrarsi del tutto con il gruppo ostile: «È la figura archetipica dell’indian fighter, la cui prima grande incarnazione è il Natty Bumpoo di Fenimore Cooper, l’eroe dell’Ultimo dei Mohicani: un bianco che dedica la sua esistenza alla guerra lungo la frontiera, finendo per non avere più un posto nella società dei bianchi, proprio perché troppo abituato a vivere come un indiano».
Un modello, questo, ripreso anche da Corvo rosso non avrai il mio scalpo! (Sydney Pollack, 1972), da Balla coi lupi (Kevin Costner, 1990) e dal meno conosciuto Grey Owl (1999), basato su una storia vera e diretto, con grande dovizia di particolari, da Richard Attenborough. In tutte queste pellicole, il silenzio è un elemento chiave: dal piccolo Caleb di Pollack, rimasto muto in seguito al trauma dello sterminio della sua famiglia da parte dei guerrieri Blackfeet, alla donna (bianca) amata da John Dunbar/Kevin Costner, adottata dalla tribù dei Sioux Lakota dopo che i genitori vennero uccisi dai Pawnee; fino al silenzio più radicale, ossia quello degli animali (e dei loro diritti ignorati), i veri protagonisti del film di Attenborough.
Ma è con il capolavoro di Miloš Forman Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975), tratto dall’omonimo romanzo di Ken Kesey pubblicato oltre dieci anni prima, che il silenzio assume la forma aperta di una protesta sociale e politica: Capo Bromden non parla ma, come si vede nell’intera storia, è forse l’unico consapevole (insieme al protagonista) di trovarsi in un ospedale psichiatrico non per un reale bisogno ma perché escluso dalla società. Ed è proprio questa consapevolezza a renderlo non solo amabile agli occhi del pubblico, ma anche risolutivo: da uomo taciturno, estraneo al mondo, diventa il deus ex machina della trama e l’unico a riuscire a fuggire.
Nel libro Dances With Stereotypes. La rappresentazione linguistica e visuale dei nativi americani: una prospettiva multimodale (Ombre corte, 2018), Lorena Carbonara analizza lo stretto rapporto tra il linguaggio e la rappresentazione occidentale dei nativi americani nella cultura cinematografica di ieri e di oggi: saranno, infatti, proprio gli anni Novanta e Duemila a dotare di voce i nativi americani e ad abbandonare quelli che nell’opera vengono definiti stereotipi (e non più archetipi).
È il cinema indipendente ad accompagnare lo spettatore attento in una realtà in cui i nativi americani sono dotati di parola, di umorismo e personalità, a partire da Smoke Signals (Chris Eyre, 1998) un road movie in cui i dialoghi sono l’elemento portante di un viaggio alla scoperta delle proprie identità.
E si potrebbe aggiungere il recentissimo Rez Ball (Sydney Freeland, 2024), dove lo sport (in questo caso il basket), la competizione, le luci della ribalta e il desiderio di riscatto sociale entrano nelle riserve, dando vita a personaggi che nulla hanno da invidiare ai teen drama interpretati dai bianchi degli anni Duemila.
«La Renaissance del cinema nativo di questo secolo, definito da Casey R. Kelly “a crafting counter-cinema”», scrive Lorena Carbonara, «è legata al concetto di sovranità, cioè alla riappropriazione della narrazione linguistica e visuale di sé in atto nelle comunità native d’America».