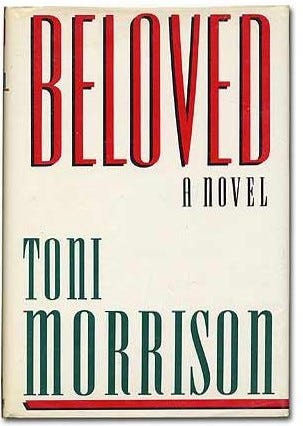Raccontare i mille volti della violenza
Il tema della violenza è essenziale nella letteratura e nel cinema d'oltreoceano, perché profondamente legato alla Storia e alla cultura degli Stati Uniti
«I bianchi credevano che, qualunque fosse la loro educazione, sotto ogni pelle scura si nascondesse una giungla. Acque vorticose non navigabili, babbuini che si dondolavano gridando, serpenti addormentati, gengive rosse pronte a succhiare il loro sangue dolce di bianchi. [...]
Ma non era la giungla che i negri avevano portato con sé in quel posto dall’altro posto (vivibile). Era la giungla che i bianchi avevano piantato loro dentro. E cresceva. E si allargava, si allargava prima, durante e dopo la vita, fino a coinvolgere i bianchi stessi che l’avevano creata. Li rendeva crudeli, stupidi, più di quanto non volessero esserlo, tanto erano spaventati da quella giungla di loro creazione. I babbuini urlanti vivevano sotto la loro pelle bianca, le gengive rosse erano le loro». (Amatissima, Toni Morrison, Sperling & Kupfer, collana Frassinelli)
La violenza descritta da Toni Morrison nel suo capolavoro Amatissima (1987) ha il sapore del sangue e delle lacrime; ha il volto della furia e i gesti della sopraffazione; è un fantasma che tormenta ogni uomo e che infesta ogni casa degli Stati Uniti. Quando si imbatté nell’articolo uscito nel 1856 sull’American Baptism, Toni Morrison capì di essere di fronte a una storia terribilmente potente: una schiava, Margaret Garner, aveva ucciso sua figlia e tentato di fare lo stesso anche con gli altri tre, senza successo. Era fuggita, insieme a tutta la famiglia, dal Kentucky, dove viveva in schiavitù, per raggiungere l’Ohio, uno dei primi Stati abolizionisti. Ritrovata e catturata, decise che l’unico modo di evitare ai suoi figli l’orrore di quella vita fosse la morte. Fu un caso che scosse l’opinione pubblica e che portò a un lungo processo: può uno schiavo, ossia qualcuno che non ha diritti, essere responsabile dell’omicidio della sua prole, ossia qualcosa che appartiene anch’essa al padrone? Può la violenza diventare l’unica salvezza per chi non ha più speranza? Il libro di Toni Morrison, in realtà, ci pone di fronte a una verità ben più amara: non è possibile sfuggire alla violenza (né tantomeno alla spirale infinita che produce) perché è dentro di noi, è la giungla che cresce nella nostra anima, che si allarga e che piantiamo nel corpo degli altri. E anche quando pensiamo di averla messa a tacere, quando crediamo di averla relegata nel ricordo, nell’immobilismo di un passato inglorioso, non smetterà mai di tormentarci, come un fantasma. La violenza perseguita gli Stati Uniti nella misura in cui la società tende a rimuoverla, a cancellarla, a offuscarla.
Per Edgar Morin il cinema non è solo uno specchio della realtà, ma il modo in cui la realtà stessa si trasfigura: è un fenomeno complesso, come recita il titolo di una sua raccolta (Sul cinema. Un’arte della complessità, 2021, Raffaello Cortina Editore), in cui lo spettatore si confronta con ciò che vive nell’ombra, con le paure della società e i suoi miti fondativi. Rappresentare la violenza attraverso il mezzo cinematografico significa raccontare una parte importante della Storia e della cultura americane, un nodo cruciale e mai sciolto. Ma significa anche raccontare i molteplici volti che può assumere.
Il petroliere (2007) di Paul Thomas Anderson racchiude la violenza primigenia degli Stati Uniti: in un film di oltre due ore non solo assistiamo al capitalismo più brutale, ma anche alla distruzione etica, sociale e morale dei rapporti umani. Il self-made man, l’archetipo dell’immaginario americano, è letteralmente un uomo che scava la terra in cerca dell'oro nero a mani nude e, soprattutto, sfruttando le mani degli altri; è colui disposto a rinnegare qualsiasi cosa (persino Dio e il figlio) pur di raggiungere il suo scopo. È un Abramo che rinuncia a essere padre e che, a differenza del vero Abramo biblico, rifiuta qualsiasi salvezza divina. È una violenza subdola, insinuante, degna di un libro di Flannery O’Connor – che sapeva raccontare la ferocia dell'umanità e della vita, meglio di chiunque altro, perché lei stessa ne era stata vittima. Il petroliere non solo si inserisce nel nutrito filone cinematografico che dimostra quanto la nascita di una nazione sia un processo intimamente violento (da David W. Griffith con i classici The Birth of a Nation, 1915, e Intolerance, 1916, fino a Gangs of New York di Martin Scorsese, 2002, non dimenticando tutto il genere western), ma modella una crudeltà che, da sempre, tormenta le forme narrative americane: quella dei falsi profeti.
Nel 1970 Stuart Hargman un giovane regista di meno di trent’anni con poca esperienza nel mondo del cinema (il suo percorso è fino a quel momento soprattutto televisivo) vince il premio della giuria a Cannes, raccontando proprio una storia di violenza e falsi profeti in Fragole e sangue. La San Francisco della controcultura e delle proteste degli universitari è il terreno ideale per mettere in guardia dagli inganni della società americana. Simon, uno studente poco incline alla politica e alle questioni sociali, si ritrova suo malgrado coinvolto nello sciopero organizzato dai ragazzi dell’ateneo. E se dapprima, attraverso il suo sguardo estraneo e cinico, vediamo le fratture di un mondo (quello dei giovani che protestano) anch’esso avvelenato dall’autoreferenzialità e da vuoti incolmabili, da frasi fatte e slogan ripetuti, è solo alla fine che capiamo dove si annida la vera violenza: quando la Guardia Nazionale picchia brutalmente gli studenti radunati in palestra, mentre cantano Give Peace A Chance. E proprio in quel momento, quando il sangue si confonde con il pavimento e i ragazzi che poco prima sembravano smarriti nelle loro stesse idee vengono massacrati e trascinati via, Simon non può far altro che capire da che parte stare e rispondere con la stessa brutalità, in un fermo immagine rimasto nella storia del cinema.
Esiste una violenza che nasce dalla disillusione profonda verso il sogno americano, che si nutre della rassegnazione nei confronti di un sistema feroce e trae la sua forza dalla certezza che se la società ti spinge ai margini, probabilmente non hai più nulla da perdere. È il caso, ad esempio, dell’antieroe interpretato da Al Pacino nel film di Sidney Lumet Quel pomeriggio di un giorno da cani (Dog Day Afternoon, 1975): una rapina in banca è l’occasione per mostrare come la violenza sia spesso la risposta (sbagliata, ma forse l’unica possibile) a un mondo che non ti vuole e che non sa cosa farsene di te. È un tema, l’esclusione sociale, che si trasforma in aggressività, che affonda le radici già in film come Forza bruta (Jules Dassin, 1947), ma che trova la sua completa realizzazione nel cinema dolente degli anni Settanta, con gli antieroi reduci del Vietnam, smarriti e disillusi, ingannati da un Paese che li ha abbandonati (basti ricordare i protagonisti de Il cacciatore di Michael Cimino, 1978). E sarà proprio un reduce del Vietnam, pochi anni dopo, a creare un nuovo canone di violenza: Rambo (1981) non è solo l’antieroe segnato dall’orrore della guerra, ma è soprattutto colui che vuole ripristinare l’ordine morale delle cose, che vuole riportare la giustizia laddove non esiste più. E per farlo usa la stessa ferocia che il suo Paese gli ha riservato.
La violenza è dentro di noi e quando la incontriamo nel mondo dobbiamo chiederci se sia, in realtà, solo il nostro riflesso, o il riflesso delle nostre paure: La cosa di John Carpenter (1982), in cui un’entità aliena capace di assorbire qualsiasi forma umana e imitarla infesta una base americana in Antartide, è la rappresentazione più pura della violenza, della brutalità che alberga in noi, e che si adatta al terrore, che vive di pregiudizi e di speranze.