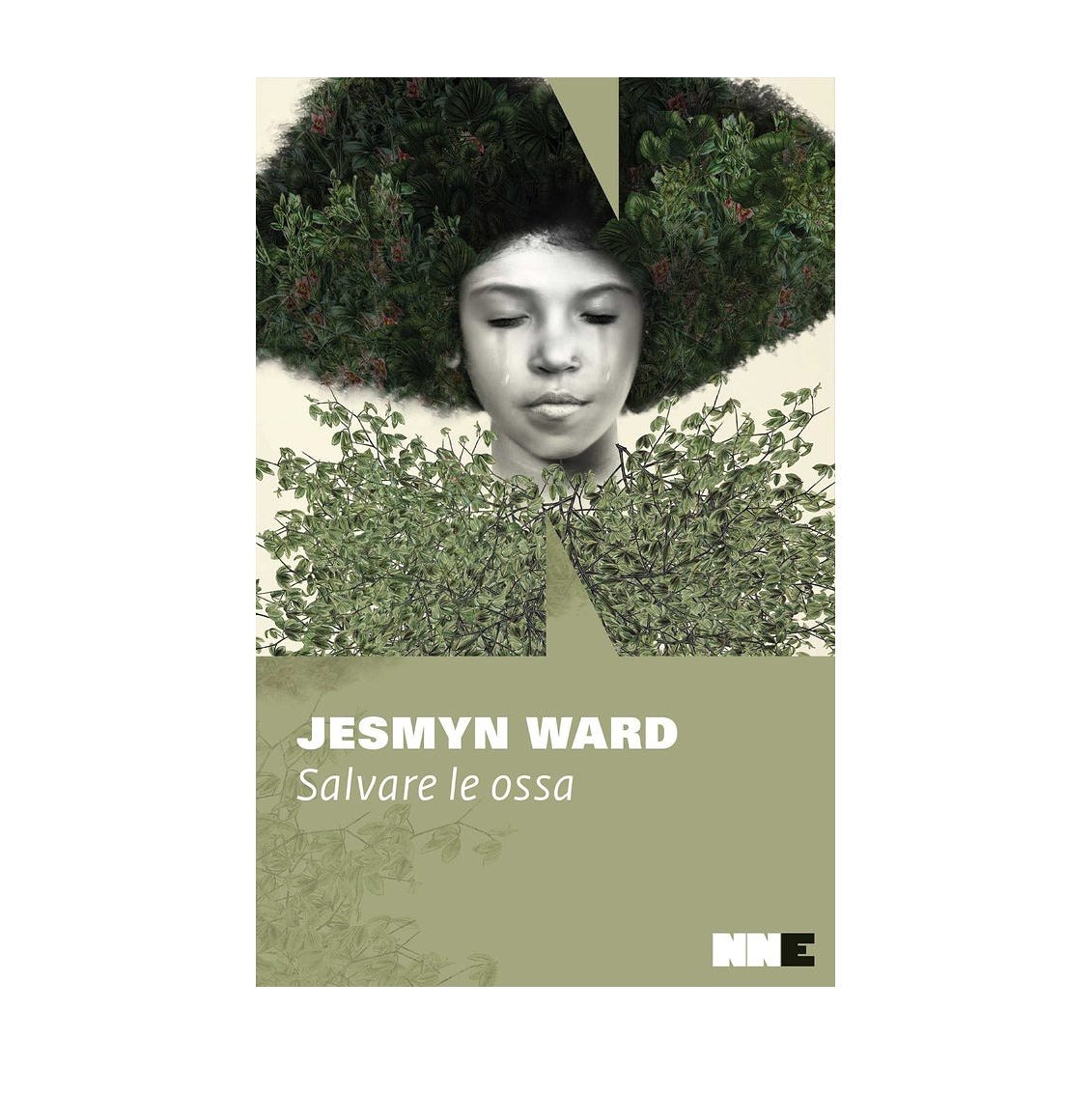L’umanità nuda: le catastrofi come specchio dell’anima
Raccontare uragani, alluvioni e disastri naturali, da John Hersey a Jesmyn Ward: quando la scrittura deve misurarsi con la tragedia.
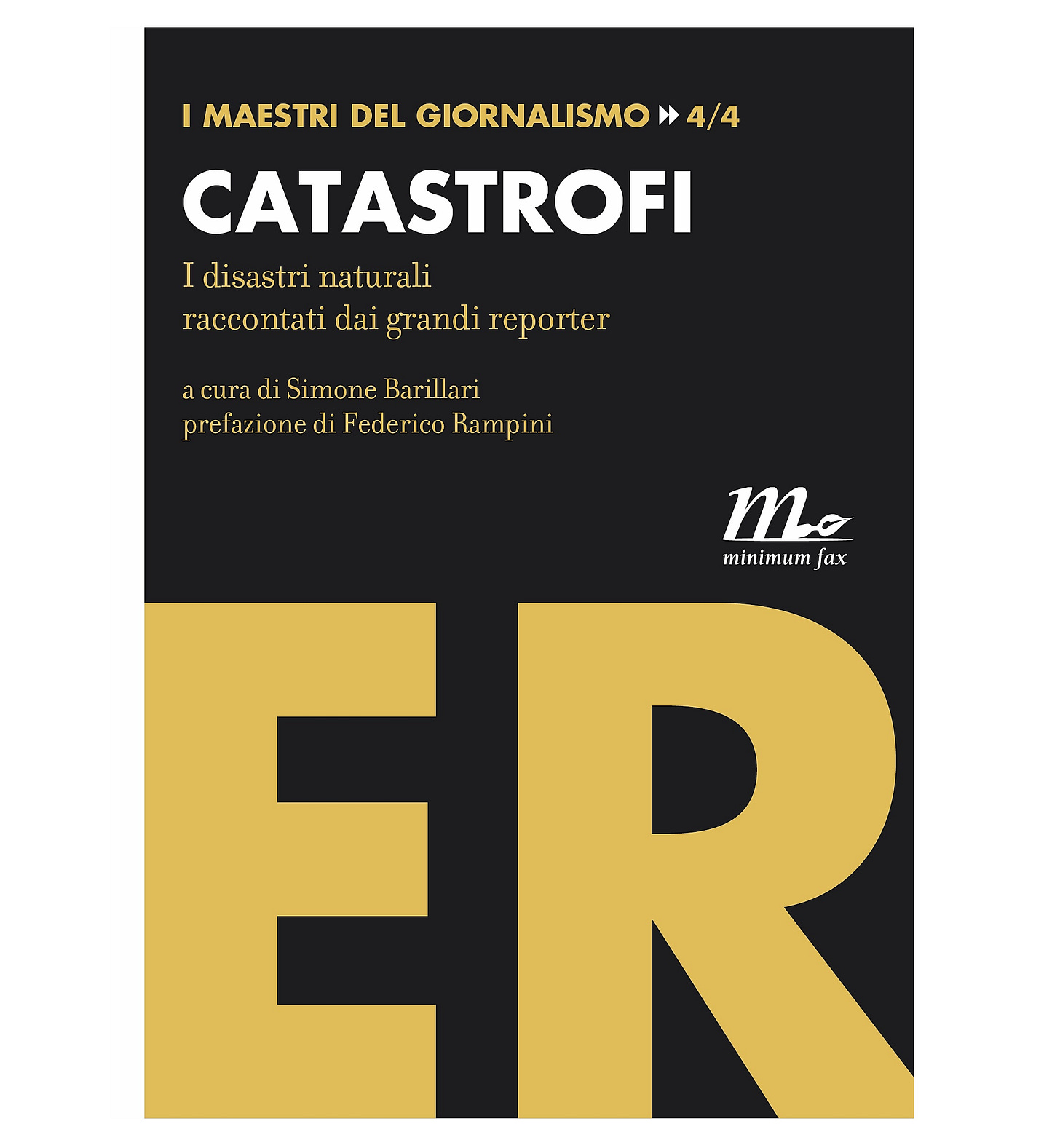
«Seduto su un barile nero in mezzo al fetore e alla melma vicino al ponte di St. Claude Avenue, Daniel Weber, un uomo di 52 anni, è scoppiato a piangere. Con la voce rotta dai singhiozzi, racconta di aver visto affogare la moglie e di aver trascorso le quattordici ore successive immerso nelle acque dell’alluvione, avendo come unico mezzo di salvezza un pezzo di legno trasportato dalla corrente».
Inizia così il reportage di Brian Thevenot, Keith Spera e Doug MacCash dal titolo Il vecchio West non è stato diverso dagli strascichi di Katrina, pubblicato su The Times-Picayune il 31 agosto 2005, dopo che l’uragano (uno dei più distruttivi e potenti nella storia degli Stati Uniti) si era abbattuto su New Orleans.
Il quotidiano della città della Louisiana e il Sun Herald Biloxi non sospesero mai le pubblicazioni, e per i sei mesi successivi uscirono gratuitamente. Grazie al loro instancabile lavoro vinsero l’anno seguente il premio Pulitzer nella categoria public service, come è scritto nella prefazione della raccolta Catastrofi. I disastri naturali raccontati dai grandi reporter (minimumfax, 2015), da cui è tratto il reportage citato in apertura.
Nel doppio ruolo di testimoni e vittime, i giornalisti trovarono il modo per raccontare la tragedia collettiva che il loro Paese stava vivendo.
Quando capitano disastri simili, siamo portati ad affidarci alle immagini, a osservare increduli i palazzi distrutti, gli alberi piegati, le case abbandonate, il fango e l’acqua che invadono ogni cosa, ma quasi mai riusciamo a collegare la potenza della tragedia con le vicende di singoli esseri umani: ascoltiamo distratti il numero delle vittime, consapevoli che i nostri corpi sono ben lontani da quelli immersi nell’acqua, o sotto le macerie.
Il reportage di The Times-Picayune parte invece da un unico corpo, quello di Daniel Weber, un uomo di mezz’età, che ha compiuto suo malgrado un’impresa straordinaria, ossia sopravvivere aggrappato a un pezzo di legno per 14 ore, un tempo infinito. Sarebbe potuta essere una storia a lieto fine, se non fosse che poco prima ha visto morire sua moglie, senza poter fare nulla per salvarla. È l’immagine più nitida che l’articolo ci offre: in mezzo, tra il corpo di Daniel Weber e le sue parole finali pronunciate davanti ai soccorritori («Non ce la farò»), c’è un’umanità sfigurata, che ruba ciò che può dai negozi o che, al contrario, si arma per difendere ciò che è suo, inconsapevole che il caos ignora la proprietà privata.
Di fronte agli atti di sciacallaggio, agli uomini che irrompono nei supermercati per prendere tutto quello che vogliono, un vigile del fuoco chiede: «Ma c’è un uragano: cosa te ne fai di un canestro da basket?».
È una domanda legittima, ma basterebbe ricordarsi che le persone continuano a essere ciò che sono anche nella tragedia.
«È in una catastrofe che gli esseri umani capiscono di che cosa sono fatti loro e quelli che li circondano», scrive John Hersey in Una storia di morte e coraggio, (sempre contenuto nella raccolta edita da minimumfax) quando sul finire dell’agosto del 1955 l’uragano Diane si abbatté sul Connecticut.
Ma è forse un altro suo articolo, dedicato alla stessa tragedia e pubblicato tempo dopo sul New Yorker, che ci mostra cosa significhi essere davvero nel mezzo di un disastro.
Hersey sceglie di raccontare la storia della signora Jessica Kelly, 75 anni, vedova, che, dopo una vita ordinaria e qualche risparmio messo da parte, è costretta a salire su una corda per salvarsi dall’acqua. Il pezzo è una pietra miliare nella storia del giornalismo, tanto si avvicina alla profondità di un romanzo, conservando però i tratti decisi della cronaca. Il passaggio di Diane nel 1955 lasciò dietro di sé 91 morti: un numero come un altro, che leggiamo rassicurati dal fatto che è un evento lontano da noi, stavolta anche nel tempo. Eppure la signora Kelly, arrampicata sulla corda con il suo cappotto, e preoccupata di portare con sé l’inseparabile borsa, rimane nella nostra mente, ben più di qualsiasi fotografia.
I disastri naturali non si limitano ad avere un impatto sulla vita di chi li subisce, ma scalfiscono in modo indelebile anche i corpi.
Il romanzo di Jesmyn Ward Salvare le ossa (NNEditore, 2018) è la cronaca di un destino irreparabile, quello di Esch, quindicenne che vive con la sua famiglia (composta da soli uomini) a Bois Sauvage, nel Mississippi, in un luogo ostile e povero, fatto di baracche, cani e umidità. È il 2005 e l’uragano Katrina sta per colpire la Fossa (così viene chiamato il loro pezzo di terra): Esch ha appena scoperto di essere incinta e cerca di nasconderlo a suo padre, ai fratelli e al ragazzo che ama. Il vento soffia sempre più forte, e la famiglia Batiste si prepara: come fosse un rituale, inchioda le assi di legno alle finestre, prepara le scatole di cibo, raccoglie acqua potabile e benzina, trasformando la casa in un tempio inaccessibile e oscuro. Ma non basta: perché, come ci ha insegnato Euripide (di cui Esch legge Medea), la potenza della tragedia e del caos distrugge le vite e i corpi degli esseri umani. Ovvero, mostra ciò che è nascosto, sbagliato, feroce: «[...] fuori si sta meglio solo perché soffia un vento forte, un vento che mi preme addosso i vestiti e rivela il mio corpo per quello che è».
Gran parte del libro è l’inevitabile attesa del disastro, dell’evento che cambierà ogni cosa: la pancia di Esch che cresce, deformando il suo corpo, e l’uragano che si avvicina, minacciando di distruggere il suo piccolo mondo, fragile e violento. Se esiste una possibilità di salvezza, Jesmyn Ward la lascia intravedere nella forza dei legami, malati, sbagliati, ma indissolubili; e nel potere del prendersi cura del dolore dell’altro.