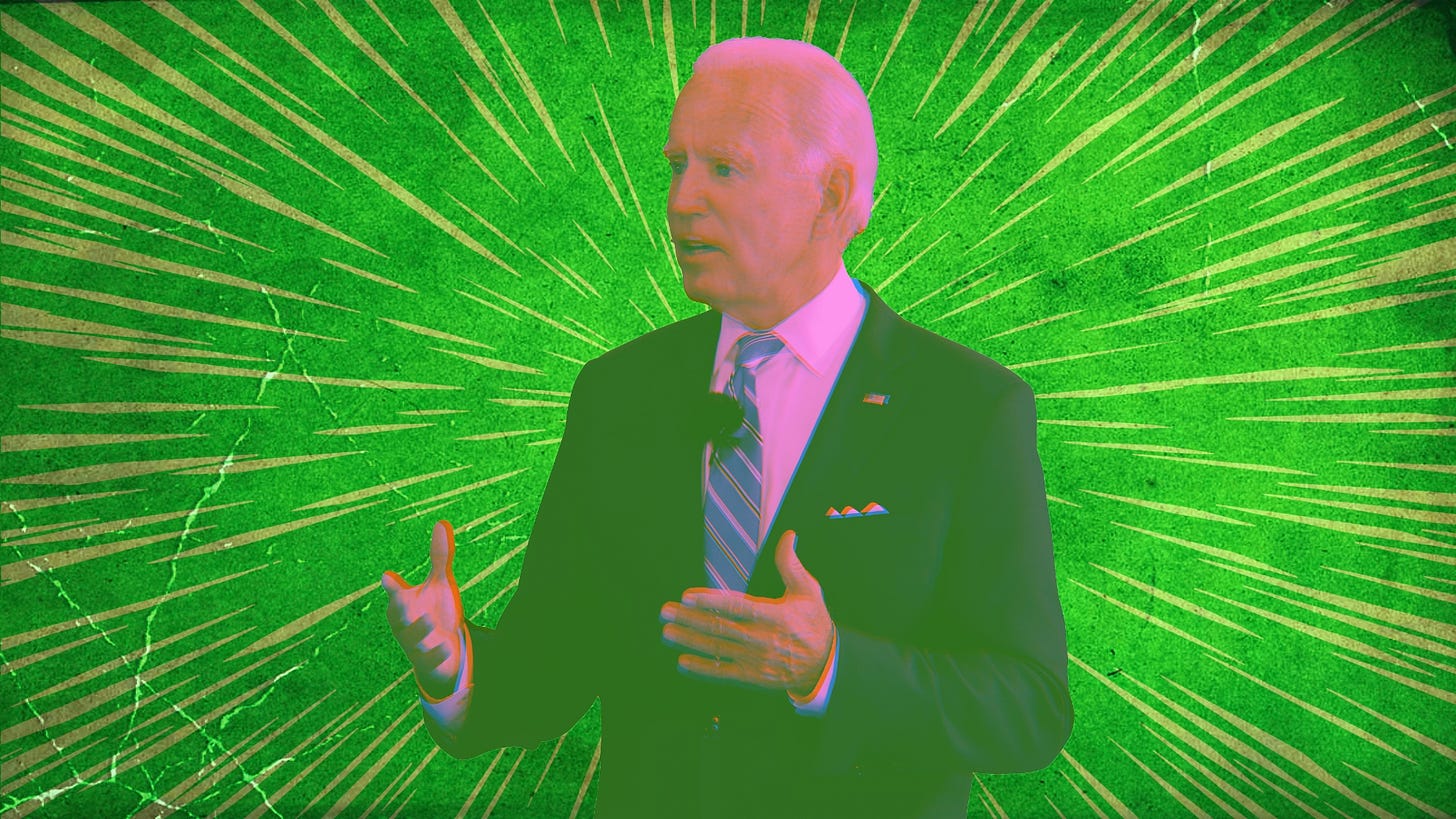La nuova diplomazia green americana
L’intuizione dell'amministrazione democratica è che la transizione energetica e la conversione verso un’economia verde devono creare nuovi posti di lavoro stimolando l'economia.
Quando si vuole capire la serietà di una strategia di politiche per un settore specifico bisogna guardare a due elementi principali: in primis alla strutturazione delle leggi che compongono quelle politiche, alle analisi da cui derivano, e alla profondità delle risposte che forniscono a problemi complessi; in secondo luogo, ça va sans dire, ai soldi che si intendono investire in quell’ambito. È sufficiente, dunque, guardare ai trilioni per la transizione energetica nel piano delle infrastrutture della amministrazione Biden-Harris e ai piani multilivello del Green New Deal per poter affermare che sì, molto probabilmente i dem fanno sul serio sul clima.
A questi si aggiunge un altro fattore: inutile ripeterlo ma, in un mondo globalizzato, quando un governo vuole mettere in atto delle politiche trasformative, qualsiasi sia l’ambito ormai è necessario elaborare strategie anche sul piano internazionale per fronteggiare gli effetti generati dall’interconnessione e dalla dipendenza reciproca. Se negli ultimi anni abbiamo visto in atto questo meccanismo in maniera macroscopica sulle politiche sanitarie, un altro ambito che talvolta svicola dalle dinamiche strettamente nazionali è senza dubbio quello del cambiamento climatico.
Quindi, affinché funzioni il piano nazionale volto alla transizione ecologica, per ridurre il riscaldamento globale gli Stati Uniti sono costretti ad aggredire le logiche del mercato energetico internazionale. L’obbligo è di connettere il livello nazionale a quello internazionale per raggiungere risultati soddisfacenti, credibili e magari convertibili in consenso elettorale. Per quanto cinico possa apparire, quest’ultimo dato rappresenta la possibilità di mettere in cassaforte i sostegni necessari a raggiungere quegli obiettivi: far passare i provvedimenti a livello federale superando gli ostacoli di una maggioranza risicata al congresso; superare le reticenze a livello dei singoli Stati che magari fondano le loro economie sui combustibili fossili, alimentando aziende che danno lavoro a milioni di persone, la cui crisi metterebbe in ginocchio le loro famiglie.
L’intuizione di questa nuova amministrazione democratica, per quanto possa apparire banale, ma politicamente futuribile è che la transizione energetica e la conversione verso un’economia verde non solo non devono mettere a repentaglio i posti di lavoro ma devono crearne di nuovi stimolando le economie. La partita si gioca almeno su due fronti: quello interno e quello esterno. Se il primo fronte presenta numerose insidie (come la maggioranza risicata al Senato e l’ostruzionismo di importanti industrie) anche il secondo non è da meno.
Concentrandoci sul fronte esterno spicca l’obiettivo diplomatico di trasformare la lotta al cambiamento climatico in uno dei pivot per la riconquista della leadership globale statunitense ad opera dell’amministrazione Biden. Il navigato neopresidente, con anni d’esperienza nelle trattative tra i corridoi del Senato, vuol ridare credibilità allo standing internazionale statunitense e per farlo punta su diplomazia e multilateralismo per coinvolgere nella sfida climatica anche i partner più reticenti, Cina e Russia comprese. Nel nutrito programma elettorale si spinge ad abbinare l’emergenza climatica alla sicurezza nazionale, la cui protezione è il più alto degli scopi per il governo e la politica statunitense. In esso, si ribadisce che l’amministrazione Biden non si sarebbe limitata a rientrare negli accordi di Parigi, ma che avrebbe rilanciato la sfida globale per la lotta al cambiamento climatico integrando “climate change into our foreign policy and national security strategies, as well as our approach to trade”.
Per raggiungere questo obiettivo, Biden ha nominato John Kerry come inviato speciale per il clima, mandandolo in giro per il mondo con il compito primario di garantire un coinvolgimento pieno degli alleati storici (Unione Europea in prima fila) su questo tema. Le task specifiche sono: decarbonizzare le industrie, abbattere i costi delle energie rinnovabili, finanziare le transizioni verdi, abbattere le emissioni non solo attraverso la progressiva diminuzione dell’uso di combustibili fossili nelle industrie ma anche nei trasporti, e molto altro ancora.
Dopo la fine dell’amministrazione Trump, gli ostacoli internazionali principali a questa “rivoluzione dell’energia pulita” sono da un lato quei paesi che producono energia non rinnovabile a basso prezzo e dell’altro lato quei paesi che hanno beneficiato di quell’energia per raggiungere lo sviluppo economico. E, d’altronde, da qualche parte bisogna pur iniziare e l’occasione c’è stata con l’incontro interministeriale su clima ed energia del G20 tenutosi a Napoli il 22 e 23 luglio 2021. Da soli, gli Stati del G20 producono ben l’80% delle emissioni globali di gas serra.
Con questo summit e l’attesa COP26 delle Nazioni Unite del prossimo novembre a Glasgow, gli Stati Uniti puntano progressivamente a riacquisire credibilità sui grandi temi del Soft Power occidentale, spostando verso il loro tradizionale campo da gioco liberale il confronto e la competizione con la Cina. La tattica per coinvolgere il colosso asiatico prevede di spacchettare le trattative diplomatiche sul clima da altri temi come i diritti umani e la democrazia, anch’essi considerati come pivot alla pari per la nuova strategia di politica estera statunitense. È ancora presto per giudicare se questa strategia sia troppo ambiziosa, con un gioco al rilancio che si dipana su più tavoli, ciononostante la sua complessità sembra corrispondere alla gravità della posta in palio.
I carteggi di Jefferson sono e rimarranno sempre gratuiti. Se vuoi sostenere il lavoro della redazione…